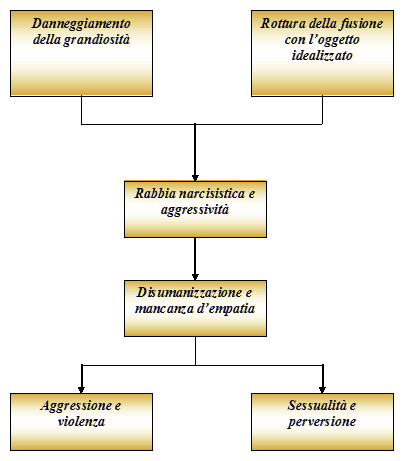L'aggressività
L'aggressività è un istinto. Dal momento che è stato nominato, vediamo cosa si intende per istinto,prima di parlare dell.aggressivitàGli istinti sono componenti dell.inconscio, pulsioni primordiali che spingono gli individui ad agire. Primordiali indica che fanno parte degli esseri viventi fin dalla nascita. Essi spingono ad agire nelsenso del soddisfacimento immediato di un bisogno. Ad esempio il mantenersi in vita è un istinto e spinge gli esseri viventi a ricercare quelle condizioniaffinché si realizzi la sopravvivenza: spinge a nutrirsi, a ricercare il cibo quando si ha fame e a berequando si ha sete. L.aggressività, come detto poco sopra, fa parte degli istinti. Essa consente di difenderci, dipreservarci nel momento in cui avvertiamo il pericolo e rappresenta l.espressione delle tendenzeattive dell.uomo. Nel momento in cui un individuo si sente minacciato e non può fuggire, la pauraprende il sopravvento e l.aggressività, come difesa, si esprime attraverso l.ostilità, la violenza e ladistruzione di ciò che minaccia la nostra integrità. Si definisce aggressiva una persona che si pone verso l.altro con ostilità, che si impone consenso di. In generale qualsiasi persona (come quasi tutti gli animali) attaccata, minacciata di .
arroganza, urlando e utilizzando atteggiamenti violenti.
Comportamenti aggressivi fanno parte della natura umana e possono essere riconosciuti nel cattivo
carattere, nella meschinità, nell.invidia e nell.arroganza. Si tratta di comportamenti che spesso sono
causa d.infelicità nella persona e richiedono la spesa di molte energie nel tentativo di dominare e
attenuare gli effetti dannosi da essi prodotti.
Alcune forme di aggressività sono di fondamentale importanza per l.esistenza quotidiana. Nel
lavoro come nei piaceri è necessaria una certa dose di aggressività per soddisfare l.istinto di
conservazione.
Esistono fondamentalmente due tipi di aggressività:
- l.aggressività intesa come istinto alla conservazione è quella che spinge gli individui ad
imporre le proprie esigenze, ad agire per preservare il proprio benessere ed è rappresentata
dall.energia che si impiega nell.affrontare gli ostacoli;
- l.aggressività distruttiva è rappresentata dall.ostilità, dalla violenza. Essa nasce da un
sentimento di paura. L.aggressività come ostilità è presente in persone scontente,
insoddisfatte delle proprie condizioni di vita. Se c.è qualcosa che non possono ottenere, sia
un bene di prima necessità o semplicemente qualcosa di piacevole, viene attivato un
perdita.
un furto o di un danno, sviluppa una certa dose di aggressività.
Gli aspetti dell.aggressività
Sono due essenzialmente le strade che può seguire l.aggressività:
- palese ed esplicita e si esprime nel comportamento attraverso l.arroganza, l.irascibilità, latendenza alla lite e ad opprimere gli altri attraverso rimproveri o urla;
- mascherata, che non si nota, non si vede apparentemente, ma che può essere espressa daatteggiamenti del tutto opposti: calma eccessiva, comportamenti estremamente educati,eccessiva sottomissione all.autorità, eccessiva gentilezza ed educazione. Questa aggressivitàè repressa, bloccata nell.inconscio, nel senso che la persona non consente a questo istinto difare parte della propria concezione globale della vita e di sé. Questo perché l.aggressivitàscatena angoscia e viene avvertita come un pericolo. Per spiegare il concetto di aggressività inconscia occorre sottolineare che in tutti gli esseri viventiesistono istinti aggressivi, ma in genere è molto difficile accettarne l.esistenza: si tende a svalutarli, minimizzarli, senza tener conto della loro importanza. Non li osserviamo direttamente, ma li teniamo al margine del nostro campo visivo e non permettiamo che entrino a far parte della nostraconcezione globale della vita. Mantenendoli un po. confusi essi non appaiono vividi, reali, vitali equindi non ci spaventano come se li vedessimo chiaramente.Perché allora, l.aggressività è un istinto che ci crea tanti problemi, pur avendo degli aspetticonservativi, volti cioè a mantenere la nostra sopravvivenza?La spiegazione o una delle spiegazioni è da ricercare nell.educazione, nell.ambiente in cui si è cresciuti, nelle regole e nei principi morali che vengono trasmessi attraverso l.educazione, a cominciare dal rapporto madre/bambino.
L'aggressività nel bambino
Come già accennato precedentemente, il compito dell.inconscio è quello di preservare il benessere el.equilibrio della struttura psichica e per fare questo tende ad eliminare ogni elemento che creadisturbo.Tale equilibrio si sviluppa in noi fin dalla tenera età: da piccoli siamo più a contatto con l.inconscio in quanto dobbiamo ancora apprendere le norme comportamentali e le sovrastrutture necessarie per convivere con gli altri, affrontare la vita quotidiana, essere inseriti nella società e nel lavoro. Il bambino cerca di ottenere immediatamente ciò che desidera per raggiungere il proprio benessere e il maggior piacere possibile ed è guidato dal suo inconscio molto di più rispetto all.adulto. La persona adulta è .adattata. alla società cioè ha imparato a controllare la propria aggressività edaderire ad un insieme di regole, norme sociali e leggi a cui siamo sottoposti. Nel bambino il compito di incanalare l.aggressività è dato in prima istanza dai genitori. L.aggressività è un istintoche il bambino sperimenta già molto precocemente nel rapporto con la madre, ad esempio quando isuoi bisogni di succhiare il latte dal seno materno vengono frustrati. La frustrazione è legata al fattoche la madre non sempre è pronta a soddisfare il bisogno del bambino. Il bambino lasciato in predaal desiderio di attaccarsi al seno, avverte un forte disagio e frustrazione che sperimenta comeaggressività verso la madre.L.aggressività del bambino legata al desiderio di volere tutto e subito, trova opposizione da partedei genitori che cercano di incanalarla ed educarla adattandola ai principi sociali, morali e culturali.Nel bambino si scatena un.opposizione al modellamento imposto dai genitori, perché egli tendecomunque a voler raggiungere il soddisfacimento del proprio istinto. rimangono dentro di noi e ci accompagnano per tutta la vita. Cosa accade allora? La risposta si può rappresentare con un esempio. E. la situazione in cui in una famiglia nasce unfratello. Il bambino, che per un certo numero di anni è cresciuto da solo e su cui si sono riversate leattenzioni e l.amore dei genitori, vede ora le loro cure rivolte più all.ultimo nato. Ciò che il fratellomaggiore percepisce è di essere deprivato dell.amore e dell.attenzione che i genitori gli rivolgevanoprima in modo totalitario. Questa situazione scatena nel primogenito degli istinti aggressivi verso ilfratello minore. La sua aggressività va nel senso della eliminazione del fratellino al fine di avere di nuovo tutte le attenzioni e l.amore per sé. Il desiderio aggressivo di eliminare il fratello si scontraperò con la morale. Che strada prenderanno allora gli istinti aggressivi? C.è la possibilità che il fratello maggiore dia libero sfogo a ciò che sente e allora sarà ostile ed odierà il fratellino. Oppure la sua aggressività, scontrandosi con le regole dettate dai genitori, darà vita ad un senso di colpa per cui essa verrà camuffata e si trasformerà in atteggiamenti totalmente opposti ed eccessivi: un.esagerata gentilezza verso il fratello, una grande paura che gli capiti sempre qualcosa (in realtà è la sua aggressività inconscia volta ad eliminarlo che vorrebbe che gli capitasse qualcosa). Il fratello maggiore avrà degli atteggiamenti di iperprotezione e cura verso il fratello minore. Comportarsi diversamente, cioè in modo oppositivo nei confronti dei genitori, significa perdere l.amore dei genitori stessi. Per evitare che si creino conflitti interiori che vadano a minare quell.equilibrio psichico, senza il quale viene meno il benessere, gli istinti aggressivi vengono messi da parte, vengono cioè prossimi paragrafi. Queste prime esperienze rimossi.
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che l.aggressività può prendere diverse strade: può manifestarsi in modo esplicito oppure, scontrandosi con le regole e la morale tramadatateci con l.educazione, può dare vita a un senso di colpa per il quale essa verrà camuffata in atteggiamenti che apparentemente non farebbero pensare alla presenza di questo istinto. Nel meccanismo per cui l.aggressività viene tramutata in atteggiamenti opposti, come eccessiva gentilezza e compiacenza, come detto sopra, ha un ruolo fondamentale. Il sentimento di colpa si esprime in molti modi e anche in questo caso, come per l.aggressività, può essere cosciente oppure inconscio. Il senso di colpa cosciente è espresso da frasi del tipo: mi sento in colpa. sento in colpa per averlo ferito ..Il senso di colpa inconscio si esprime invece attraverso vari comportamenti, vissuti e sentimenti come ad esempio avere in ogni occasione la sensazione di essere scorretto, di non essere all.altezza della situazione, di essere respinto. Quando esiste un sentimento di colpa inconscio la persona vive in funzione dell.opinione altrui, ha spesso paura di essere criticata e biasimata e cercherà di fare di tutto per essere perdonato ed accettato. in altri casi la sensazione d.inferiorità determinata dal senso di colpa inconscio fa sì che la persona, proprio per arginare il senso d.insicurezza e timidezza, assuma comportamenti rigidi, stereotipati oppure molto educati ed accondiscendenti, soprattutto verso i superiori. Da dove nasce il senso di colpa? ll senso di colpa nasce nel momento in cui avviene un conflitto tra l.inconscio e la morale, intendendo come morale tutti i principi, le regole e le norme che vengono trasmesse attraverso l.educazione. L.inconscio ha la funzione di mantenere l.equilibrio e il benessere della struttura psichica. A tale scopo sviluppa desideri ed impulsi che possono contrastare con l.educazione, la morale e le regole che ci hanno insegnato. Da tale conflitto nasce il sentimento di colpa, molto spesso inconscio. Nell.esempio del ragazzo cui nasce un fratello, il sentimento di colpa si sviluppa nel momento in cui, invece di dimostrare la sua rabbia, diventa eccessivamente gentile e iperprotettivo. Il sentimento di colpa inconscio nasce dal conflitto tra istinti aggressivi verso il fratello e la morale cosciente che invece spinge il ragazzo a porsi verso il fratello con estrema amorevolezza ed attenzione. La paura che sta dietro a tutto ciò è di perdere l.amore dei genitori. Un altro esempio è il caso di Silvia, 38 anni che si rivolge ad uno psichiatra per un problema di depressione. Lo psichiatra le consiglia d.iniziare una psicoterapia. Negli incontri Silvia porta tutto il suo disagio: è triste, malinconica, ha spesso voglia di piangere, non ha amici, né un fidanzato. Fa la commessa, ma da circa un anno ha perso interesse per il suo lavoro. Si alza alla mattina e sente su di sé tutto il peso della giornata. Silvia commenta così: arrivasse domani così la farei finita con tutta questa tristezza ... . poi arriva la sera e mi prende una tristezza infinita. Vorrei non Silvia vive con il padre di 68 anni. La madre è morta otto anni addietro e circa un anno dopo ilpadre ha un ictus. Da allora Silvia gli dedica tutto il suo tempo libero. Il padre, in passato, era stato molto possessivo e rigido nei suoi confronti: e se uscivo, mi faceva ritornare a casa prima di tutti gli altri amici .Quando ho avuto il primo ragazzo, a 18 anni, non ne parliamo: lo ha scoperto e mi ha contrastato a tal punto che ho preferito chiudere l.amicizia ... ragazzo. Il padre diventava tanto più iroso quanto più la figlia dimostrava qualsiasi cenno di indipendenza. Era invece affettuoso ed amorevole se lei gli stava vicino e gli ubbidiva. Silvia afferma di avere deciso di seguire il padre per dovere morale: stato male ha problemi a camminare. E. solo, mia madre è morta. Da solo come farebbe? Io non riesco a pensarlo da solo, non riuscirei a farmi la mia vita e pensare a lui che, poveretto, soffre la solitudine ed inoltre non potrei allontanarmi . lui mi vuole accanto a sé . mi ha sempre voluta vicino... . Quando ero adolescente non voleva che io uscissiSilvia si sentiva in colpa ogni volta che pensava di uscire con un. . Poverino, da quando è Nel corso di otto mesi di terapia Silvia riesce ad esprimere la sua aggressività verso il padre rivisitando la sua gioventù: lui; quando morirà io rimarrò sola perché per lui non ho dedicato tempo a costruirmi una famiglia e delle amicizie . lo odio ... . è stato un grande egoista . io ho sacrificato tutta la mia vita per Silvia dentro di sé nutriva molta rabbia nei confronti del padre, ma proprio questa aggressività, ha creato in lei un senso di colpa insostenibile. Unica soluzione per conservare un equilibrio della sua dimensione psichica è stato di rendere inconscia l.aggressività ed assumere un atteggiamento opposto, cioè di soccorso, amore e cura per il padre.
La rimozione
Nei paragrafi precedenti si è parlato di istinti aggressivi inconsci. Come fanno questi istinti a diventare inconsci e a rimanere tali? Ciò avviene attraverso un meccanismo chiamato che ha la funzione di rimuovere contenuti non accettati dalla coscienza e renderli inconsci. La rimozione è un meccanismo di difesa rispetto a contenuti o istinti, come l.aggressività, che entrano in conflitto con la nostra coscienza e che determinerebbero una frattura dell.equilibrio psichico della persona. E.un processo inconsapevole, mediante il quale vengono chiuse le vie che conducono alla coscienza, a contenuti incompatibili con essa. Il fine è quello di ricacciarli da dove sono venuti, cioè dall.inconscio. La rimozione è un meccanismo di l.equilibrio della personalità e il benessere interiore che andrebbero persi se gli istinti emergessero nella nostra coscienza. Si tratta di una difesa che deriva dalla continua ed automatica tendenza normativa dell.Io. L.Io è la parte organizzata della nostra personalità e il suo compito è quello di svolgere da intermediario tra gli impulsi che arrivano dall.inconscio che non conoscono tabù, interdizioni, permessi e le esigenze della realtà che ci circonda e il Super-Io. Esso è costituito dai principi morali e dalle regole che sono stati trasmessi dai genitori attraverso l.educazione. E. un compito piuttosto arduo in quanto gli impulsi che derivano dall.inconscio, per loro natura, spingono verso un soddisfacimento immediato. L.Io mette in atto dei compromessi tra l.inconscio e la realtà, affinché il primo venga parzialmente soddisfatto nel rispetto delle regole e norme appartenenti alla realtà e al Super-Io. Riporto un esempio clinico per spiegare meglio questi meccanismi. Roberto ha 38 anni, è un ingegnere elettronico e lavora nel settore della programmazione. Inizia un percorso di psicoterapia per un disturbo da attacchi di panico comparso circa due anni prima, in concomitanza dell.acquisto di un alloggio dove va a vivere da solo, dopo aver vissuto per anni conla madre. Anche nel settore lavorativo, nello stesso momento, si verifica un cambiamento: viene promosso ad un ruolo di maggiore responsabilità. Roberto si presenta come una persona molto trattenuta: non parla mai di emozioni o sentimenti, appare molto controllato e tende a cercare sempre una motivazione razionale e concreta a ciò che capita. Non ricorda i sogni. La sua giornata è occupata prevalentemente dal lavoro che lo impegna anche Sabato e Domenica. E. stato molto rigoroso nello studio, affrontando gli esami con uno stato d.ansia che si presentava già alcuni giorni prima della prova. Anche nel periodo universitario le sue relazioni sociali erano ridotte e non conserva un buon ricordo di quel periodo. Ha un senso del dovere fortissimo, tende a volere raggiungere sempre il massimo, vuole la stima degli altri dimostrando la sua perfezione e il suo rigore nel lavoro. Quando riesce ad ottenere un buon risultato, il suo ideale di perfezione lo spinge a dovere ricercare un altro compito più arduo da risolvere, non riuscendo a godere del risultato raggiunto. Vive con grande frustrazione i propri errori in campo lavorativo che comunque sono davvero pochi, visto il suo ipercontrollo e la tendenza alla perfezione. Durante le sedute cerca di controllare molto le sue emozioni, i suoi racconti sono privi di tonalità emotive, non descrive mai .come si sente.. I genitori gli hanno trasmesso un forte senso del dovere. Il padre, morto circa dodici anni fa, è sempre stato un uomo severo. Roberto è cresciuto in un ambiente dove non ha mai potuto .lasciarsi andare., mostrare la sua emotività, il suo entusiasmo, perché considerati dal padre manifestazioni.femminili.. Roberto, per conservare l.amore e la stima del padre, è costretto a non esprimere la sua emotività e le sue sensazioni. In questo modo viene quindi rimossa la parte dei sentimenti e delle emozioni mentre si è sviluppata in modo eccessivo la parte razionale. La vita di Roberto è tutta espressione disentimento di colpa. Vediamo meglio di cosa i tratta.. . mi sono comportato così, ma ora mi, . . durante quella lite con mio padre gliene ho dette di tutti i colori e ora mi.
questa parte: ha scelto un percorso di studi fortemente razionale, non ha spazio per coltivare le
sensazioni e i sentimenti (non ha una ragazza e ha pochi amici). La sua emotività però emerge in
modo esplosivo e angosciante attraverso i sintomi, gli attacchi di panico.
Attraverso il percorso di psicoterapia, sta cercando di lasciare spazio alle sue parti emotive. Dopo
un anno di terapia i sintomi sono regrediti e Roberto comincia a nominare, se pur con difficoltà, le
emozioni e le sensazioni che prova.
rimozione,difesa perché difende
L.angoscia
L.angoscia è una reazione emotiva di terrore che si manifesta con l.imminenza di un pericolo e si
produce dinnanzi al pericolo fattosi improvvisamente attuale.
L.angoscia consente di individuare dunque l.esistenza di un pericolo e per tale motivo ha una
funzione biologicamente utile in quanto, essendo un campanello d.allarme, consente di poterlo
affrontare.
Occorre però fare una distinzione tra angoscia reale e angoscia nevrotica.
La prima è quella che emerge di fronte ad un pericolo reale e consente l.attivazione di tutti quei
meccanismi biologici ed emotivi che sono necessari per difendersi attraverso la fuga o l.attacco.
La seconda,
Le manifestazioni dell.angoscia nevrotica si possono raggruppare essenzialmente in tre modalità
espressive:
-
collegati ad alcun oggetto in particolare, ma sono pronti a rivolgersi a qualsiasi oggetto e
trovare in quello una giustificazione d.essere. Questi stati d.angoscia sono dolorosi, penosi
intollerabili per chi li prova e si manifestano sia a livello fisico che psichico. Fisicamente si
possono provare spasmi viscerali digestivi, vampate di caldo e freddo, sudorazione
eccessiva, difficoltà a respirare regolarmente a causa di una sensazione di costrizione alla
gola o al petto, tachicardia, irrigidimento muscolare. A livello psichico si può vivere la
sensazione di impazzire, avere la sensazione di fallire in tutto, di non avere speranza nel
futuro.
-
luoghi o situazioni oggettivamente privi di pericolo;
-
improvvisamente e violentemente senza nessuna causa apparente e reale.
L.angoscia raramente è situata in superficie e bisogna ricercare l.origine nel profondo della
personalità, cioè nell.inconscio mentre la persona avverte solo la presenza della sintomatologia. Tali
sintomi sono coscienti mentre l.angoscia di base, di cui essi sono l.espressione, è inconscia e la
persona non ha la minima sensazione di essere angosciata.
Le soluzioni più frequenti che si adottano contro l.angoscia sono:
- fare qualsiasi cosa per evitare che si manifesti: lavorare molto, uscire spesso, bere, fare uso
di sostanze stupefacenti, avere una vita piena di impegni o prendere tranquillanti;
-
attività altruistiche;
- iniziare un percorso di psicoterapia per capire quali siano le fonti da cui l.angoscia prende
origine.
L.angoscia compare in seguito alla percezione di un pericolo. In genere il pericolo è determinato
dalla vita istintuale, che nel momento in cui tende ad emergere, spesso si scontra con le norme, le
regole, la morale e l.educazione. Tale scontro determina un senso di colpa che dà origine
all.angoscia. Per fare fronte all.angoscia si mettono in moto meccanismi di difesa come ad esempio
la rimozione, allo scopo di rendere inconscio l.istinto ed assumere comportamenti che danno
sicurezza.
Il modo in cui aggressività, angoscia e colpa sono collegate si può vedere nell.esempio riportato
della nascita di un altro bambino in una famiglia in cui è già presente un altro figlio.
I genitori rivolgeranno più cure al nuovo nato e, il primogenito, che fino ad allora ha avuto per sé
tutto l.amore e le cure dei genitori, si sente deprivato a causa del fratello. Il senso di benessere e
l.equilibrio che fino ad allora aveva vissuto vengono meno. Il suo inconscio cerca di ristabilire
l.equilibro interiore e la modalità più diretta è quella di eliminare la causa che ha determinato la
rottura del benessere.
Succede che:
- il ragazzo prova degli istinti aggressivi inconsci, ma leggermente avvertibili per il fratello
(prova dei sentimenti di odio, desidera allontanarlo, eliminarlo);
- si genera angoscia dovuta al fatto che gli impulsi aggressivi inconsci tendono ad emergere,
ma si scontrano con le regole dettate dai genitori;
- si genera un senso di colpa dal conflitto tra istinti aggressivi che provengono dall.inconscio
e la morale;
- per risolvere questo conflitto ed eliminare l.angoscia che da esso si genera, si mette in atto la
rimozione che spinge l.aggressività da dove è emersa e cioè nell.inconscio.
Tale meccanismo determina un comportamento opposto all.istinto inconscio: il ragazzo potrà
dimostrarsi particolarmente gentile e affettuoso e sviluppare un.iperprotezione verso il fratello.
l.angoscia nevrotica, si manifesta invece in assenza di un pericolo reale.le nevrosi d.angoscia in cui esistono stati d.angoscia permanenti e fluttuanti che non sonol.angoscia che si produce nelle fobie emerge nei confronti di animali del tutto inoffensivi,attacchi isolati d.angoscia (per esempio i disturbi da attacchi di panico), che si manifestanosublimare l.angoscia, trasformarla cioè in azioni positive quali ad esempio dedicarsi ad
Aggressività, angoscia e colpa nel rapporto psicoterapeutico
Aggressività, angoscia e colpa emergono anche nella relazione psicoterapeutica, luogo in cui si crea
una riedizione delle modalità di relazionarsi con le figure genitoriali e con gli altri.
All.inizio di una psicoterapia è difficile parlare di sé e delle proprie esperienze con una persona in
fin dei conti sconosciuta: lo psicoterapeuta.
Pensare di mettersi a nudo, parlare della propria sofferenza e delle proprie difficoltà con un estraneo
può essere fonte di angoscia.
Come può anche esserlo pensare di affrontare argomenti penosi o temere l.affiorare di ricordi o
vissuti traumatici o ancora considerare aspetti di sé che non si accettano o di cui si ha un.idea
negativa.
Abbiamo detto che nel rapporto psicoterapeutico, si ha una riedizione nel presente dei rapporti
primari. Una persona che ha avuto un.educazione molto rigida per cui .non poteva lasciarsi andare.
e si sentiva amato dai genitori solo nel momento in cui era perfetto, controllato, riporterà anche nel
rapporto psicoterapeutico questi vissuti e cercherà di essere compiacente. Un paziente .modello.,
controllato, proverà l.angoscia di essere rifiutato nel momento in cui sentirà affiorare emozioni che
potrebbero ridurre il suo controllo.
L.angoscia emerge assieme alle resistenze e questo avviene quando ci si avvicina ai meccanismi
che determinano il malessere o quando vengono messi in luce aspetti indesiderati della propria
personalità.
L.aggressività può emergere anche nel momento in cui ci si avvicina a vissuti che il paziente non
vorrebbe affrontare.
Essa può diventare una resistenza alla terapia stessa ed esprimersi non in modo diretto ma
camuffato.
Nel concreto si possono verificare lunghi silenzi, ritardi rispetto all.orario della seduta, sedute
saltate, atteggiamenti di svalutazione rispetto al terapeuta e all.utilità della terapia.
Si può vedere come l.aggressività emerga in modo camuffato nel corso di una psicoterapia, nel caso
che esporrò qui di seguito.
Anna è una donna di 40 anni che ha iniziato il percorso di psicoterapia da circa un anno. Mi viene
inviata da uno psichiatra a cui si è rivolta spontaneamente a causa di un disturbo d.ansia che
lamenta di avere dall.età di 20 anni. Anna si è rivolta gia in passato ad altri specialisti come
psichiatri e psicoterapeuti, ma non ha mai risolto il suo problema.
Il disturbo di cui soffre si esprime attraverso vari sintomi: tachicardia, forti vertigini che la
costringono a stare a letto, paura del buio e fobia dello sporco.
La fobia dello sporco, la porta a temere di essere infettata da qualsiasi cosa tocchi al di fuori della
propria casa. Stringere la mano ad una persona, significa lavarsi più volte e spendere anche ore a
lavarsi e non essere mai sicura di essere pulita. Per questo motivo Anna ha ridotto ampiamente le
relazioni sociali e spesso si assenta dal lavoro.
La paziente cresce in una famiglia conflittuale, sperimenta la violenza legata alle liti dei genitori tra
un padre autoritario e una madre ambivalente anche nei suoi confronti. Attualmente vive con la
madre settantenne da cui è molto dipendente, il padre è morto dieci anni fa.
La prima volta che vedo Anna mi comunica che non ce la fa più a vivere così e vorrebbe liberarsi di
questa fobia che le
non essere compresa e di essere giudicata, come è accaduto frequentemente nella sua storia
familiare. I suoi racconti anche i più traumatici, sono privi di tono emotivo, ha difficoltà a esprimere
ciò che prova. Spesso, anche se non vengono nominate, le sue emozioni mi giungono in modo
molto diretto e così mi capita di provare angoscia, commozione e tristezza.
Nel corso delle sedute Anna da un lato afferma:
nessuno..
in modo camuffato.
Riporto alcuni stralci di sedute:
.rende la vita impossibile. . Mostra molto imbarazzo a parlare di sé, teme di. qui posso raccontare cose che non ho mai detto a, dall.altro invece sento che la sua aggressività emerge e si rivolge conto di me anche se
15° seduta
Anna arriva molto raffreddata e con qualche linea di febbre. Le faccio notare che avrà fatto un
grande sforzo per venire in seduta. Lei mi risponde:
volevo saltare la seduta.spero di non attaccarle l.influenza e di spargerle tutti i microbi per la
stanza, apra le finestre dopo...
non emergono emozioni. Mi fa molti apprezzamenti su come sono vestita, in realtà la mia
sensazione è che ci sia molta aggressività nei suoi complimenti. Sul finire della seduta, emergono
ricordi di situazioni traumatiche relative ai sui genitori.
Nel momento in cui ci salutiamo afferma:
debba stare a casa per l.influenza...
Con questa frase Anna mi esprime tutta la sua aggressività rispetto al sentirsi dipendente dalla
relazione psicoterapeutica. Non riuscire a saltare la seduta malgrado l.influenza e dover dipendere
da una relazione per stare meglio è causa di rabbia. Si riproduce nel rapporto terapeutico con me ciò
che vive nel rapporto con sua madre: ha bisogno di lei a causa delle sue fobie, ma nello stesso
tempo questo bisogno la imprigiona in una relazione di forte dipendenza.
La differenza fra piano reale e piano psicoterapeutico sta nel fatto che, attraverso la relazione
terapeutica, si mette in moto un processo per cui è possibile passare da uno stato di dipendenza al
tentativo di individuarsi e divenire indipendente
:..oggi sto meglio ieri stavo malissimo, nonPer gran parte della seduta Anna rimane su un piano concreto,.Spero che la prossima settimana lei ci sia e che non.
20° seduta:
La settimana precedente, Anna disdice l.incontro che avevamo spostato. Quando la paziente arriva
per la seduta, si scusa per avere disdetto la volta scorsa, solo il giorno prima, portando come
giustificazione il fatto che si erano rotti dei tubi nel bagno e che quindi aveva dovuto chiamare il
tecnico che sarebbe venuto il mattino in cui avremmo avuto la seduta. In realtà Anna aveva preso
accordi con l.idraulico in modo tale da finire i lavori in tempo per essere presente all.incontro con
me, ma malgrado questo la mamma le aveva chiesto di disdire comunque la seduta perché non
voleva rimanere da sola con l.idraulico nell.eventualità che il disguido si fosse prolungato. In
seduta la paziente afferma:
madre perché i lavori si sono prolungati!
qui inutilmente vero?.
continua affermando:
vederla proprio il giorno di festa in cui lei non c.era. Quel giorno avevo proprio bisogno di
parlarle, ma lei non c.era..
.mi scusi dottoressa se ho disdetto, ma meno male che ho ascoltato mia.Spero che l.abbiano avvisata in tempo.non è venutaLa rassicuro sul fatto che la comunicazione mi è arrivata in tempo. Anna..menomale. così ha dormito di più.poi in realtà avevo bisogno di
Ho riportato alcuni passaggi di questa seduta in quanto si può notare come l.aggressività possa
essere espressa in modo mascherato: Anna ha problema di dipendenza dalla madre, che non ha mai
aiutato la figlia ad emanciparsi, ma ha sempre cercato di tenerla accanto a sé, vivendola come unico
scopo della propria vita dal momento che la sua vita coniugale è sempre stata molto conflittuale e
frustrante. Anna si è trovata spesso ad oscillare tra il prendere le parti della madre e altre volte del
padre e ogni volta in cui prendeva le parti dell.uno si sentiva in colpa per essersi schierata contro
l.altro. Da quando il padre è morto il legame con la madre è diventato ancora più forte. Questo
legame ora sta diventando troppo soffocante. Mentre da un lato Anna ha difficoltà ad immaginare la
sua vita senza sua madre, dall.altro afferma di essere stufa di non avere amici, una relazione
sentimentale, di passare tutte le festività con sua madre di cui si sente
la badante.
Aderire al setting e nel caso specifico venire in seduta in un giorno diverso dal solito, stabilito non
da lei ma da me, suscita in Anna vissuti di dipendenza. La paziente tollera con difficoltà questi
vissuti in quanto sono quelli che vive nella relazione con sua madre in cui si sente imprigionata e
da cui vorrebbe emanciparsi, ma di cui non riesce fare a meno. Sentirsi dipendente dalla relazione
terapeutica suscita in Anna aggressività
seduta. Anna ha difficoltà ad accettare i propri aspetti aggressivi e infatti afferma
l.abbiano avvisata così non è venuta fino qui inutilmente...
. Questa aggressività si esprime proprio nel saltare la.spero che
Probabilmente quello che avrebbe desiderato comunicare a parole, poteva essere una frase del tipo:
.Perché devo venire un giorno in cui dice lei, considerando che nel momento in cui avevo bisogno,
lei non c.era?..... Anna ha invece .agito. la sua aggressività saltando la seduta.
Come detto precedentemente, l.aggressività può emergere quando, attraverso il rapporto
psicoterapeutico emergono contenuti, vissuti o aspetti di sé che la persona ha difficoltà ad accettare
e considerare come parte integrante della sua personalità.
A tal proposito, nella stessa seduta, la paziente mi racconta un sogno fatto la sera precedente, ( è il
primo sogno che mi porta in seduta).
Anna sogna una grande inondazione, lei è in casa ed affacciandosi alla finestra vede l.acqua salire e
teme che lei e la sua casa vengano travolte.di colpo l.acqua scompare.
Dopo avermi raccontato il sogno le chiedo quali emozioni associa al sogno, lei risponde:
.Mi sono svegliata agitata e affannata, è stato un brutto sogno..
Le chiedo cosa le faccia venire in mente, mi risponde che
parlare del giorno in cui lei non c.era e io avevo bisogno di parlarle.posso saltare da un
argomento all.altro?..
.E. un brutto presagio.però vorrei
Parlare dei propri sogni significa portare al terapeuta aspetti molto intimi di sé, in quanto attraverso
i sogni si esprime il nostro inconscio. Lavorare con il terapeuta sul sogno, attraverso le libere
associazioni, consente alla persona di venire a contato con aspetti inconsci di sé e ciò può
spaventare, considerando che la persona può venire a contato con vissuti, emozioni, parti di sé che
.non gli piacciono. e che, proprio per questo motivo vengono spostati fuori dalla coscienza. Nel
caso di Anna l.emozione negativa l.avvisa che quel sogno ha dei contenuti angoscianti, per cui la
paziente evita di parlarne e salta ad un altro argomento mostrando aggressività verso di me che in
qualche modo le ho chiesto di dirle cosa le faceva venire in mente, portandola quindi a riflettere su
qualcosa per lei doloroso. L.aggressività viene espressa nella frase riportata sopra in modo
camuffato e che detta in altre parole probabilmente risuonava così: .Invece di farmi soffermare su
un sogno che mi crea angoscia, parliamo di quando io avevo bisogno di parlare con lei e lei non
c.era...
Il
paziente esprimeva aggressività
miei confronti è stata espressa ogni volta in cui ci avvicinavamo ad argomenti e situazioni che per
Anna erano fonte di angoscia.
Un altro punto da considerare, come si è visto nei paragrafi precedenti, consiste nel fatto che gli
istinti aggressivi inconsci possono causare un sentimento di colpa nel momento in cui emergono ed
entrano in conflitto con la morale cosciente. Ciò si verifica anche nel rapporto psicoterapeutico nel
momento in cui la persona prova aggressività verso il terapeuta. Da essa deriva un senso di colpa
che porterà la persona ad avere comportamenti opposti all.aggressività come ad esempio estrema
compiacenza, complimenti frequenti al terapeuta o preoccupazione eccessiva per la sua salute.
Il sentimento di colpa inconscio può anche manifestarsi attraverso la resistenza alla guarigione.
Un esempio è fornito da alcune affermazioni di un paziente affetto da depressione in terapia
farmacologica e psicoterapia da circa due anni presso un servizio pubblico.
Franco è un uomo di 42 anni, impiegato, che soffre di depressione da circa cinque anni, attribuisce
l.inizio della depressione alla morte del padre per un tumore. Dalle sedute emerge che Franco è
sempre stato un ragazzo dal temperamento pacato, chiuso e riferisce di aver portato dentro di sé un
senso di malinconia profonda. Il padre viene descritto come un uomo severo e burbero, che ha
impartito un. educazione rigida al figlio, da cui pretendeva buon rendimento scolastico e successo
nella carriera. Franco racconta che spesso da piccolo avrebbe desiderato un rapporto più intimo con
il padre, fatto di momenti trascorsi insieme a lui a giocare, a fare la lotta, a parlare, ma il padre:
.
padre senza esprimere emozioni sempre con lo stesso tono di voce, poi nel corso delle sedute inizia
ad emergere una certa rabbia per il fatto che il padre non avesse avuto mai tempo per lui e che si
interessasse al lui solo per assicurarsi del suo rendimento scolastico. La rabbia però lascia
immediatamente spazio alla giustificazione
poveretto, e voleva che io arrivassi ad avere una buona posizione economica migliore della sua.
La rabbia di Franco viene immediatamente smorzata dal senso di colpa. Dentro di sé Franco nutre
un grosso rancore verso il padre, che non lo ha mai gratificato affettivamente e che inoltre è sempre
stato autoritario e duro anche con la madre. In realtà ha nutrito e nutre ancora un grande amore per
suo padre, l.odio per lui nasce dal fatto di non essere riuscito ad averlo accanto a sé come avrebbe
desiderato. Ha dentro di sé un grosso senso di colpa che nasce da un aggressività inconscia verso di
lui. Questi vissuti sfociano in un disturbo depressivo con la morte del padre.
Con il tempo Franco sta elaborando queste dinamiche ma il senso di colpa agisce in modo molto
pregnante nella sua vita e anche sulla terapia. Infatti, in un periodo in cui si sente meglio dice:
controtransfert è lo strumento che mi ha aiutato ad individuare i momenti, gli argomenti dove la. Riflettendo sull.andamento del nostro percorso, l.aggressività neinon era tagliato per queste cose, lui era un grande lavoratore.. Inizialmente Franco parla del: .mio padre si comportava così perché lavorava molto.
..avevo l.impressione di stare meglio nei giorni scorsi.è un.assurdità.se continuo così mi
libero del mio malessere e allora provo la sensazione di potermi sentire ancora più in colpa.è
come se qualcosa dentro di me mi dicesse che non posso vivere senza quel malessere, senza quello
non riuscirò ad emanciparmi. .
.Stare meglio. si presenta come qualcosa di pauroso: Franco ha l.impressione che il suo disturbo lo
preservi da immaginari pericoli. Razionalmente tutto questo non ha una spiegazione. I suoi stati
d.animo possono invece essere interpretati come manifestazioni di un attaccamento ad uno stato di
sofferenza (la depressione) che rende molto dolorose le sue condizioni di vita, come se quelle
Da:www.depressione-ansia.it